Giuseppe Baretti a cinque anni dal terremoto
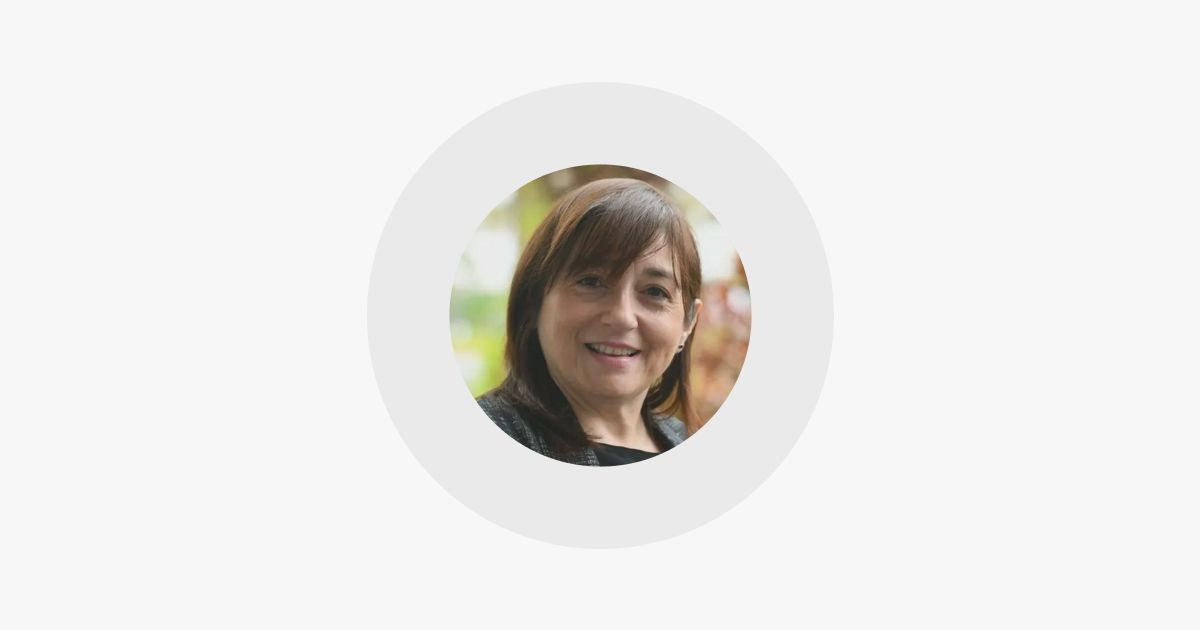
Lo scrittore, critico, traduttore e studioso torinese Giuseppe Baretti (1719-1789) si recò a Lisbona da Falmouth il 31 agosto 1760, in compagnia di Edward Southwell, barone Clifford, futuro membro del Parlamento. Il viaggio diede origine a due libri: *Lettre Familiari di Giuseppe Baretti A' Suoi Tre Fratelli Tornando da Londra in Italia nel 1760* (vol. I, 1762; vol. II, 1763) e *A Journey from London to Genoa Through England, Portugal, Spain and France * (Londra, 1770). Sebbene l'opera inglese si presenti come una traduzione della prima, la differenza tra * Lettre Familiari* e *A Journey* è considerevole, rendendoli unici. Non si tratta di un aspetto di poco conto, perché, quando si considera la prospettiva di Baretti sul Portogallo, è necessario tenere presente che i due testi, destinati a pubblici nazionali diversi, rivelano, nei dettagli, i lettori e le loro aspettative. Profondo conoscitore della cultura inglese e stimato membro dei circoli intellettuali dell'epoca, Baretti sapeva che ciò che è apprezzato in Italia non sempre lo è in Inghilterra.

Giuseppe Baretti (1719-1789)
In entrambi i testi, più che una guida oggettiva e dettagliata, Baretti intraprende un viaggio emozionale, un viaggio alla scoperta di pensieri personali, culturali, morali, esistenziali ed etici. Di fronte a un mondo diverso dal suo, strano e straordinario (in senso positivo o negativo), attento a ciò che sembra degno di essere registrato, Baretti, usando l'umorismo appreso dagli autori italiani dell'epoca, si discosta spesso dalle convenzioni della letteratura di viaggio: privilegia l'aneddoto, offre critiche e rivela interessi e ideologie.
La curiosità attorno a Lisbona doveva essere certamente grande. L'unicità della tragedia del 1755 aveva fatto notizia in tutta Europa: è il caso del resoconto dettagliato pubblicato a Londra su *The Gentleman's Magazine and Historical Chronicle * di Edward Cave il 6 novembre 1755, appena cinque giorni dopo l'evento; senza dimenticare i riferimenti di Voltaire al terremoto in * Poème sur le Désastre de Lisbonne* (1756) e in *Candide* (1758). L'attrazione divenne ancora maggiore quando il "mondo" da esplorare era un regno le cui vicissitudini politiche, come il tentato assassinio di re José I e l'espulsione dei gesuiti nel 1759, erano oggetto di riflessione nel resto d'Europa. Il Portogallo era un regno da esaminare attentamente.
Senza nascondere la superiorità filosofica e intellettuale che avvertiva nei confronti del mondo iberico, simile a quella espressa da gran parte del mondo intellettuale inglese dell'epoca, Baretti, senza preoccuparsi di perdere terreno in obiettività e autorevolezza, costruisce un'immagine del Portogallo piuttosto poco lusinghiera. Si giustifica con il tempo limitato a disposizione e la scarsa conoscenza dei fatti, della gente e del funzionamento delle istituzioni. Mentre attenua le sue critiche al paese in * Viaggio*, affermando che gli mancava la conoscenza della lingua e il contatto con l'aristocrazia portoghese, probabilmente allo stesso ritmo dell'Europa civilizzata, in *Lettres* la sua verve umoristica è così forte da ricevere dure critiche da Ambrósio Pereira Freire de Andrade e Castro, Ministro Plenipotenziario in Austria, che non era soddisfatto delle critiche della famiglia reale portoghese: Baretti la trova troppo semplice, umile, troppo vicina al popolo, priva dell'esemplare distanza di altre case reali.

Il terremoto di Lisbona del 1755, autore sconosciuto.
Ma ciò che lo fa tirare un sospiro di sollievo quando attraversa il confine e lascia il Portogallo è quasi tutto: un popolo che probabilmente non ha nemmeno sentito la perdita dei libri nel terremoto, perché qui non sono mai stati "di moda"; che ha solo un Camões e un Osório, e anche quelli non vengono letti; che ha costruito un palazzo a Mafra sproporzionato rispetto al paesaggio e con una biblioteca piena di libri religiosi e niente di scientifico; un governo che ha espulso i gesuiti, unici garanti dell'istruzione; che ha brutte locande, molte delle quali infestate da pulci; una popolazione maleducata e maligna... Un popolo che ha fatto poco dopo la tragedia del 1755. Ignorante, arretrato, povero e poco laborioso. Non tornerà mai più in Portogallo. Non perché non voglia, ma perché il marchese di Pombal non perdonerà le sue critiche e si rifiuterà di far entrare lo scrittore italiano nel regno.
Forse ciò che meno lo predisponeva a detestare il Portogallo, tuttavia, era la sua vicinanza all'Africa in termini di costumi e popolazione: "Ma, a prescindere da ciò che credo, non pensa che il Portogallo sia molto vicino all'Africa?" ( Viaggio, 1970: 190). Una prossimità evocata anche dalla presenza di neri e mulatti in tutta Lisbona. Capitale dell'impero portoghese, crocevia tra continenti, la presenza di persone di diverse razze conferiva certamente alla città un'insolita atmosfera multietnica. Pertanto, quando descrive il Portogallo come un paese pieno di neri, dimostra il sentimento di estraneità che una società razzialmente mista gli provocava.

Cais do Sodré nel 1785, di Joaquim Marques – MNAA
Sebbene Baretti disapprovi la schiavitù, si oppone al meticciato, considerando i mulatti come "mostri umani". Nelle sue Lettere , racconta il gran numero di uomini e donne neri deportati dall'Africa in Portogallo, o nati in Portogallo da genitori africani, che "riempiono questo piccolo angolo d'Europa di una specie di mostro umano chiamato mulatti, che sono figli di un uomo nero e di una donna bianca, o di una donna nera e di un uomo bianco". Questi "mostri, a loro volta, generano altri mostri unendosi ad altri uomini e donne europei". Così, "poche famiglie portoghesi riescono a rimanere puramente europee, e col tempo tutte diventeranno meticce, cioè il sangue africano entrerà in tutte in misura maggiore o minore".
In * Viaggio *, è più specifico: un bianco e un nero generano un mulatto; un mulatto con una donna bianca genera un meticcio. Questi possono essere meticci bianchi o neri e possono naturalmente, senza impedimenti, sposare bianchi, neri, mulatti e altri meticci. Queste mescolanze esistevano a tal punto ed erano viste con tale naturalezza che il Portogallo stava depravando la razza europea originaria e persino distruggendola. Pertanto, con un pizzico di risata, sostiene che sarebbe necessario epurare sempre più la nobiltà, composta da incroci razziali, da questa nazione che si considera così nobile e la più illustre e degna di tutte le nazioni.

Picasa
Supplica alla Madonna di Atalaia (a Montijo), in Sketches of Portuguese Life, 1826.
L'idea che i discendenti di relazioni interrazziali macchiassero la purezza delle razze si diffuse in Europa con l'avvento di nuovi orientamenti pseudoscientifici basati su teorie climatologiche e razziali, al punto che, nel XIX secolo, nel suo Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane, Arthur de Gobineau sviluppò il suo pensiero sul principio della degenerazione etnica delle razze. Per l'autore, questa degenerazione derivava dalla mescolanza, dalla fragilità e dall'inferiorità delle razze meticce e delle loro nazioni necessariamente miste. Se i portoghesi si mescolarono con i neri e gli indigeni, adottandone i costumi, ciò, per il teorico francese, avvenne perché le due razze possedevano fattori di attrazione e prossimità: la razza portoghese non era poi così lontana dai difetti delle razze indigene.
Baretti si posiziona in modo etnocentrico, dando voce a un codice di valori etici ed estetici che guidano la sua visione del mondo e degli altri. Riducendo il Portogallo alla sua personale dimensione di civiltà, si concentra su eccentricità o atteggiamenti riprovevoli, che racconta con vari gradi di umorismo. Ma ci offre anche il ritratto di un regno che, nell'Illuminismo, appariva moderno in ciò che Baretti trova mostruoso: nella costruzione di una società interrazziale e inclusiva.
[Gli articoli della serie "Portogallo 900 anni" sono una collaborazione settimanale della Società Storica dell'Indipendenza del Portogallo. Le opinioni degli autori rappresentano le loro posizioni personali.]

observador





